REPORTAGE di “INTERNAZIONALE”
I migranti faranno a
pezzi le nostre bugie
·
Questo è l’articolo
scritto da un bianco sulla storia di due ragazzi neri e con ogni probabilità
sarà letto quasi esclusivamente da bianchi: racconta l’inizio della fine di
questo genere di articoli e comincia a Palermo nel 2012.
Il filo della matassa
parte dal Senegal, passa dal Gambia, arriva a Pittsburgh, tira dentro John
Fante Martin Scorsese mia zia Sarina, e finisce in Padania per massimo scorno
di leghisti e cattivisti e nuovi asini nazionalisti. Però bisogna cominciare da
Palermo.
È luglio, ci sono trenta
gradi e la città si squaglia e risolidifica in una nuova realtà fatta per
l’ottanta per cento di umidità e per il venti per cento di canicola: molti, per
comodità, definiscono questa realtà “estate siciliana”. Nell’estate siciliana
succede che molte cose rallentino o si fermino del tutto, gli uffici vanno
deserti. Chi ha bisogno deve arrangiarsi come può, ed è per arrangiare una
soluzione che il comune telefona alla scuola di lingua italiana per stranieri
dell’ateneo.
Il problema è che
mentre anche i centri di accoglienza per migranti rallentano le loro attività,
gli sbarchi non diminuiscono: 13.267 persone
sono arrivate in Italia quell’anno, 8.488 sulle coste siciliane. Tra
loro ci sono molti adolescenti. La professoressa Mari D’Agostino dice a Laura
Purpura, dirigente dell’ufficio che si occupa della loro situazione, che un
modo per non abbandonarli all’afa palermitana potrebbe essere quello di farli
partecipare ai corsi estivi della scuola.
“Potete immaginare che
cosa significhi avere avuto nella stessa classe una ragazza norvegese a Palermo
per l’Erasmus e un diciassettenne senegalese, e cercare di insegnare a entrambi
l’italiano”, racconta D’Agostino. “I percorsi che segue una persona che sta
studiando per una laurea e una che non è quasi mai andata a scuola sono
radicalmente diversi”.
Un buco nero enorme
è la Libia, ci finiscono violenze e abomini, denuncia Save the children
Da quell’estate del 2012 a oggi, senza che per i loro progetti sia
stato speso un euro, D’Agostino e il suo gruppo di lavoro si sono rimessi a
studiare, hanno costruito programmi nuovi per i nuovi ragazzi che si sono
trovati tra i banchi e alla fine, come raccontano nel libro Dai barconi
all’università, sono riusciti a insegnare l’italiano a
trecento di loro. Minori stranieri non accompagnati, come sono definiti con
un’etichetta che costruisce una realtà. Tra loro, oltre all’inizio della fine
di articoli come quello che state leggendo, c’è anche l’esplosione di queste
etichette e la messa in discussione di una retorica a cui siamo abituati. Le
storie di Ibrahima e Bakari aiutano a visualizzarla meglio.
Me le raccontano a
casa della professoressa D’Agostino, dietro il teatro Massimo di Palermo. Con
noi c’è uno dei suoi collaboratori, Marcello Amoruso, e a me viene da pensare
che siamo in commissariato. Non per la scena, ma per la struttura della scena:
tre borghesi occidentali, bianchi, appartenenti a due istituzioni, l’università
e l’informazione, di fronte a due ragazzi neri, africani, che non hanno niente,
se non le loro storie. In base a queste storie sono giudicati dalle
istituzioni, e sulla base di questo giudizio possono trasformarsi da rifugiati
in clandestini. Perciò all’inizio misurano sguardi e frasi, e c’è bisogno di
ripetere molte volte che il loro racconto non sarà pesato sulla bilancia della
legge infame che regola l’immigrazione in Italia.
Bevono una coccola, si
interrompono spesso, guardano la professoressa e Marcello, cercano
rassicurazioni nei loro occhi, parlano.
Ibrahima è nato in
Senegal e da piccolo aiuta il padre nel negozio di famiglia. Vendono stoffe e
cuciono vestiti, le giornate sono semplici. Finché la madre non si ammala e il
padre la porta in Gambia, dov’è nata e dove può curarsi meglio. A Ibrahima
tocca occuparsi del negozio.
“Sono solo e a notte
sento rumori dal negozio. Qualcuno veni per rubare la macchina da cucire. So,
io sono fight. Questo è coltello, solo io, loro tre persone, tre ragazzi più
grandi”.
Quando dice “questo è
coltello” dice della cicatrice che ha sulla fronte e del taglio sul petto e
della perdita dei sensi e del risveglio in una casa che non conosce, in un
bosco che non conosce, assieme a ragazzi che non conosce, tenuto prigioniero da
gente e per motivi che non conosce.
Dopo una settimana
riesce a scappare e a raggiungere Kaolack, 189 chilometri a sud di Dakar. Dopo
va in Mali, dopo il Mali il Niger, dopo il Niger, pausa: sono viaggi che
raccontati così non significano molto, vederli su una mappa aiuta farsi un’idea.
Il racconto quasi mai
è lineare, è pieno di vuoti e omissioni. Un buco nero enorme è la Libia, ci
finiscono violenze e abomini, come denuncia
Save the children. Ibrahima non ne parla volentieri. Dice di esserci
rimasto due anni, fino a un tentativo di rapina che finisce con lui mezzo morto
per terra. È il 2013, ha sedici anni, mette insieme dei soldi e sale su una
barca insieme a un altro centinaio di persone: ha più fortuna di altri. “Tanti
muoiono, no?”.
Bakary ascolta, tiene
gli occhi sulle punte delle scarpe e spesso annuisce con la testa. È più
silenzioso, parla meno bene di Ibrahima. Arrivava anche lui dalla Libia, e
prima ancora, a ritroso, Niger, Mali e Gambia, dov’è nato, diciassette anni fa.
Il silenzio non è dovuto solo alle difficoltà con l’italiano, e non riguarda
solo la Libia, in generale è qualcosa che riguarda la sua vita dopo lo sbarco,
i suoi giorni qui a Palermo.
“È più introverso di
altri”, dice Amoruso, “quest’anno a un certo punto non l’abbiamo più visto tra
i banchi. Dopo una settimana telefono al centro d’accoglienza dove vive e
chiedo spiegazioni: spiegazioni non ce n’erano. Bakary non si alzava dal letto
la mattina, non gli andava, non vedeva un motivo per farlo. Abbiamo chiacchierato
un po’, ha riacquistato fiducia e voglia, non ha più perso un giorno di
lezione”.
Trascrivo una sua
frase, che mi sembra tra le più belle annotate quel pomeriggio: “Mi piace il
pallone, bello, mi piace il Palermo, ma anche studio è bello (pausa, risata)
difficile però”. Questa difficoltà me la raccontano D’Agostino e Amoruso.
“Dovresti vederli in classe, alcuni si piegano sul foglio, altri impazziscono a
stare nelle righe, moltissimi non hanno mai tenuto una penna in mano”.
“Quando riescono a
superare le difficoltà, allora emergono i pezzi di un racconto epico che si sta
formando proprio sotto i nostri occhi, e a cui magari non prestiamo
attenzione”, dice la professoressa, “ma si modella anche per alimentare il
nostro bisogno di inquadrare la realtà in un certo modo”.
Un esempio può essere
quello di uno dei ragazzi del corso che ricorre alla struttura del racconto
collettivo che tutti conosciamo per non dover dare conto della sua storia
personale. Dunque, la versione ufficiale suona così: Bangladesh, fame, miseria,
viaggio verso l’Europa per trovare un lavoro e spedire qualche soldo a casa. Ma
più probabilmente è vicina a: una famiglia media, senza troppi problemi di
soldi, un’omosessualità da nascondere a tutti i costi, l’impossibilità di
nasconderla a tutti i costi, l’Europa come speranza e salvezza.
“Non è più facile, in
casi del genere, raccontarci quello che vogliamo sentirci raccontare? L’epica
collettiva semplifica la realtà e la rende più semplice da capire”, osserva la professoressa.
“Le singole storie verranno fuori più in là, e ci racconteranno più di quanto
sappiamo e vogliamo sapere noi oggi, così come è stato per esempio per
l’emigrazione italiana nel novecento”.
È a questo punto che
la storia che è partita dal Senegal, è passata dal Gambia, finisce a
Pittsburgh. Non è la prima volta che assistiamo a un flusso migratorio così
massiccio come quello che in questi anni sta facendo arrivare in Europa milioni
di persone dall’Africa e dall’oriente.
La faccenda ha riguardato anche italiani e europei,
e quello che è successo, in termini di racconto della realtà, sta succedendo di
nuovo.
In estrema sintesi: le
storie di chi scappa da qualcosa (guerra, miseria, dittature) sono in prima
battuta raccontate da chi li vede arrivare; si costruisce una retorica che si
autoalimenta (spesso con pregiudizi e razzismi vari); pian piano chi arriva
comincia ad appropriarsi di una lingua, la fa sua e inizia a raccontare la sua
versione dei fatti; la retorica iniziale frana, lo stato delle cose inizia a
mutare.
Provo a tradurre
quest’idea con qualcosa di pratico. Sono siciliano e da almeno tre generazioni
la mia famiglia emigra. Mia nonna non ha mai conosciuto un fratello, emigrato
in Argentina prima che nascesse e mai più tornato; mio padre negli anni
sessanta ha lavorato in una fabbrica a Bonn; io e mio fratello ce ne siamo
andati dopo la laurea a Roma e a Padova.
È cambiato tutto, da
allora, sono cambiati i motivi che ci hanno spinto a lasciare la Sicilia, è cambiata
la Sicilia, sono cambiati i viaggi, siamo cambiati noi: è rimasto uguale
l’incrinarsi della voce di chi resta quando parla di chi se ne va. Il dolore
per i figli i mariti i fratelli lontani, in molte famiglie siciliane, è un
basso continuo e la mia non ha fatto eccezioni, dall’autobus preso da mio padre
a diciassette anni per entrare illegalmente in Germania ai viaggi in treno da
trenta ore di mio fratello fino al suo primo volo da novecentomila lire per
Padova: non c’è stato spostamento che non abbia rotto voci e cuori.
Uno dei fratelli di
mia nonna negli anni cinquanta è partito per gli Stati Uniti, la moglie lo ha
raggiunto poco dopo, una delle loro figlie scriveva lettere a mia madre da
Pittsburgh. In una risuonano molte disperazioni, e una di queste disperazioni
ha a che fare con la lingua:
Carissima nipote
Rosetta e Totò,
scusami del mio ritardo a scriverti come stai? Spero che la prisenti vi venga a trovari a tutti di una buona salute. I sono invecchiata ma riagisco bene, solo che mi sento troppo triste e sola li vicini non ci parlo non ci capiamo, in questa terra o subito troppo dispiacere e spero a Dio che che mi da un poco di conforto nel cuore. Parlami dei tuoi figli, facci studiare la lingua, la lingua passa lu mari. Tanti abbracci a tutti, a tua mamma e a tuo papà.
Sarina
scusami del mio ritardo a scriverti come stai? Spero che la prisenti vi venga a trovari a tutti di una buona salute. I sono invecchiata ma riagisco bene, solo che mi sento troppo triste e sola li vicini non ci parlo non ci capiamo, in questa terra o subito troppo dispiacere e spero a Dio che che mi da un poco di conforto nel cuore. Parlami dei tuoi figli, facci studiare la lingua, la lingua passa lu mari. Tanti abbracci a tutti, a tua mamma e a tuo papà.
Sarina
La lettera è datata
1997, all’epoca mia zia aveva vissuto più negli Stati Uniti che in Italia, ma
la lingua era ancora una delle cose che più le torceva il sonno e la teneva ai
margini di quel paese e della sua storia. Quasi un secolo prima delle sue parole,
questo isolamento aveva i contorni di una vignetta pubblicata sul quotidiano di
New Orleans, The Mascot, nel 1888.

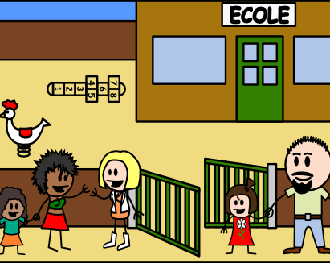 Nel ventiseiesimo capitolo del primo libro dei Saggi,
Nel ventiseiesimo capitolo del primo libro dei Saggi, Il denaro, poiché possiede la proprietà di comprar tutto, la proprietà di appropriarsi tutti gli oggetti, è così l'oggetto in senso eminente. L'universalità della suaproprietà è l'onnipotenza del suo essere, esso vale quindi come ente onnipotente... Il denaro è il lenone fra il bisogno e l'oggetto, fra la vita e il mezzo di vita dell'uomo. Ma ciò che mi media la mia vita mi media anche l'esistenza degli altri uomini. Questo è l’altrouomo per me. –
Il denaro, poiché possiede la proprietà di comprar tutto, la proprietà di appropriarsi tutti gli oggetti, è così l'oggetto in senso eminente. L'universalità della suaproprietà è l'onnipotenza del suo essere, esso vale quindi come ente onnipotente... Il denaro è il lenone fra il bisogno e l'oggetto, fra la vita e il mezzo di vita dell'uomo. Ma ciò che mi media la mia vita mi media anche l'esistenza degli altri uomini. Questo è l’altrouomo per me. –